Recensioni Vincenzo Pirrotta reinventa Pirandello in "L'uomo dal fiore in bocca", in scena allo Stabile di Catania fino al 17 novembre, portando al parossismo il suo personaggio che si attacca alle piccole grandi gioie della vita adesso che sta per lasciarla, lasciando uno spiraglio ad una speranza ultraterrena
Vincenzo Pirrotta reinventa Pirandello. Ma lo fa dimostrando grande amore e dedizione attoriale per il celeberrimo drammaturgo siciliano, che fece dell’infelicità la sua amara cifra esistenziale, con la messa in scena al Teatro Stabile di Catania (repliche fino al 17 novembre), di una delle sue opere più belle, pur nella sua fulminante brevitas, “L’uomo dal fiore in bocca”.

Vincenzo Pirrotta in “L’uomo dal fiore in bocca/Nella mia carne” in scena allo Stabile di Catania
L’attore si cala con grande maestria nei panni di un uomo sconsolato, malato terminale in attesa di morire. E lo fa con la sua solita travolgente fisicità, che riempie la scena, grigia e angosciante, lastricata da pareti mobili di lastre di raggi X, (efficace, ma forse ci è mancata un po’ l’atmosfera della stazione, metafora della vita, che è continua attesa, attesa della morte), esprimendo tutto il dolore di chi deve abbandonare la vita cui si attacca disperatamente. Dicevamo reinventa Pirandello, portando al parossismo il suo intimo personaggio, alle prese con il suo tragico “fiore in bocca”, che si attacca alle piccole grandi gioie della vita, proprio adesso che sta per lasciarla; e ben duetta con il casuale, ignaro, pacifico avventore interpretato in modo pregnante (e col giusto atteggiamento di essere offuscato dalla banalità del vivere quotidiano) da Giuseppe Sangiorgi.

Vincenzo Pirrotta e Giuseppe Sangiorgi in “L’uomo dal fore in bocca/Nella mia carne”
Il risultato è convincente grazie soprattutto a un perfetto controllo della voce, che ormai modula con grande maestria, riuscendo a passare dal ghigno all’urlo fino al soffocato e allo strozzato come pochi attori nel panorama contemporaneo (e già avevamo avuto modo di apprezzarlo nella splendida piéce “Storia di un oblio”). Più pacato nella prima parte dello spettacolo, il vero e proprio atto unico pirandelliano, Pirrotta ha dato poi il meglio di sé nel sequel da lui stesso ideato, l’inedito “Nella mia carne”, epilogo al testo pirandelliano, dove il suo corpo prorompente ha davvero dominato la scena, con dolenti mugugni di dolore, avanzando, nell’arco di sette giorni, a piccoli passi, sulle belle musiche originali di Luca Mauceri, verso la Donna ammaliante che tutti seduce.

Un’altra scena de “L’uomo dal fiore in bocca” con Vincenzo Pirrotta e Giuseppe Sangiorgi
Una lettura attenta, dunque, questa di Pirrotta, della più profonda anima pirandelliana, dominata da una misteriosa tentazione della morte, un vizio assurdo, che lo risucchiò fin da giovanissimo (famosissimo l’episodio del cadavere e dei due amanti accadutogli in uno strano fondaco buio); e da questa lettura attenta nasce una piéce originale, dove davvero il tema della morte addosso è palpabile ad ogni battuta. Parlare con un’insistenza crescente, ironica e disperata, tentando di esorcizzare l’ineluttabile destino: così Pirrotta invera e trascende Pirandello, lasciando anche uno spiraglio a una speranza ultraterrena. Suggestiva l’immagine finale dell’angelo traghettatore che intona una dolce nenia funebre, accompagnando il malato verso una nuova luce.
Alla lucida disperazione del drammaturgo agrigentino subentra dunque, nella visione dell’attore, una fede assolutamente necessaria all’uomo contemporaneo. Resta nell’aria un inno d’amore alla vita, perchè “la vita, perdio, al solo pensiero di perderla, specialmente quando si sa che è questione di giorni” è un bene prezioso, come preziosi sono i commessi che impacchettano i regali con la carta lucida, ignorando che la morte, invisibile e subdola, si impadronerà prima o poi anche di loro, donandogli purtroppo un fiore in bocca…
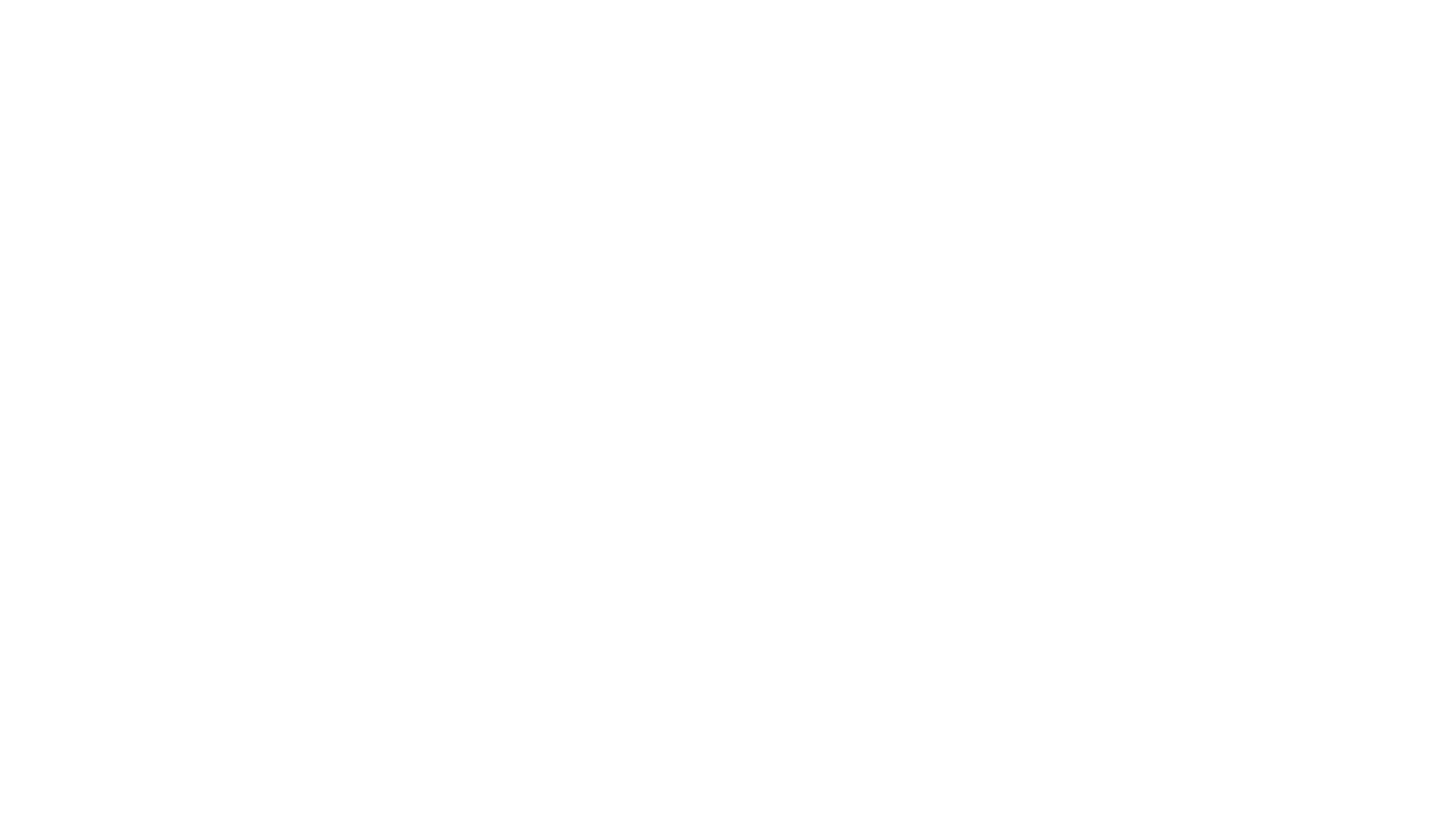


Commenti